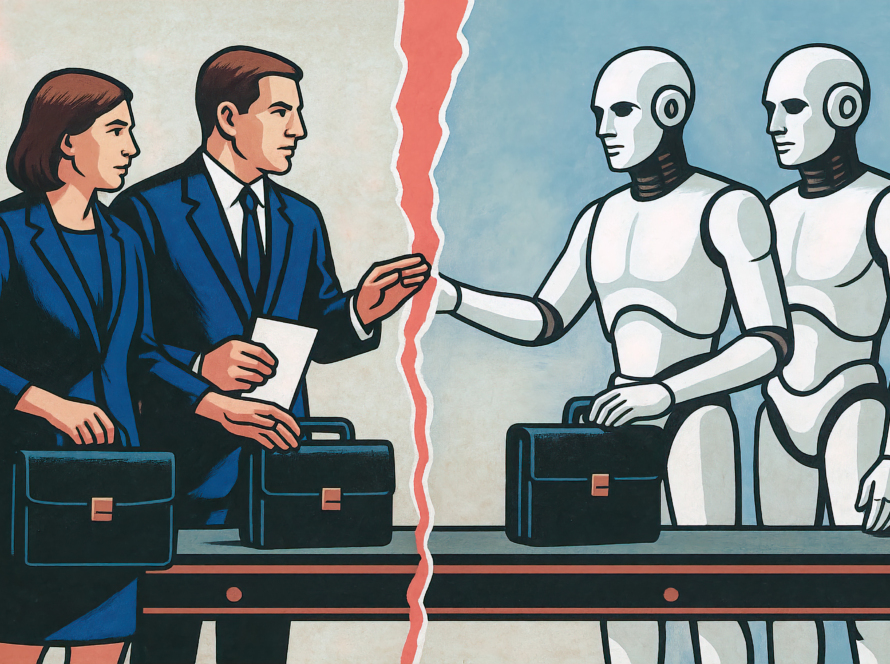Nel cordoglio per la scomparsa di una figura di rilievo come Papa Francesco, Librologica propone una ricostruzione della visione della Chiesa cattolica sull’intelligenza artificiale, apprezzandone la coerenza, la profondità e la chiarezza. Pur non condividendo alcune letture di carattere filosofico e teologico, e riconoscendo certi limiti nella comprensione delle potenzialità tecnologiche, riteniamo questa visione molto più lucida e rigorosa rispetto al racconto distorto offerto negli ultimi anni dalla gran parte dei media italiani, inclusi quelli specializzati in tecnologia, spesso faziosi e incapaci di svolgere con serietà il proprio compito informativo. Una narrazione, la loro, sistematicamente orientata a gettare discredito sulle nuove tecnologie e a generare diffidenza irrazionale nel pubblico.
Nel periodo che si aprirà con la scomparsa di Papa Francesco, mentre la Chiesa e il mondo intero ne ricorderanno la figura e il pensiero, si aprirà anche una riflessione su come le sue posizioni verranno raccolte e sviluppate dal prossimo pontefice. Tra i temi che segneranno questa transizione, l’intelligenza artificiale generativa continuerà a occupare un posto sempre più centrale. I grandi modelli linguistici capaci di produrre testi, immagini e decisioni complesse porranno interrogativi che il nuovo pontificato sarà chiamato ad affrontare con lucidità e profondità. Papa Francesco ha indicato una via fatta di apertura e prudenza, definendo l’intelligenza artificiale uno “strumento affascinante” e insieme “tremendo”, in grado di generare progresso o disuguaglianza a seconda delle scelte umane. Nei prossimi mesi e negli anni a venire, sarà il nuovo pontefice a stabilire se questa visione verrà confermata, ampliata o trasformata, e quale ruolo assumerà il tema dell’intelligenza artificiale nel cammino futuro della Chiesa.
Un nuovo orizzonte tecnologico e morale
L’avvento dell’intelligenza artificiale generativa – dai sistemi in grado di produrre testi e immagini indistinguibili da quelli umani, come i grandi modelli linguistici stile ChatGPT, fino ad algoritmi capaci di decisioni autonome – ha posto alla Chiesa cattolica sfide inedite e urgenti. Papa Francesco e il Vaticano hanno risposto con crescente attenzione a questo fenomeno, riconoscendone da un lato le potenzialità positive e dall’altro i rischi profondi sul piano etico, sociale e antropologico. In continuità con l’atteggiamento della Chiesa verso le svolte tecnologiche del passato, il Pontefice ha inquadrato l’AI non come una minaccia da demonizzare a priori, ma come uno “strumento affascinante” e al contempo “tremendo”, capace di grandi benefici o gravi danni a seconda di come l’umanità saprà guidarlo. Tale duplice consapevolezza – entusiasmo per l’innovazione e prudenza morale – caratterizza la posizione ufficiale della Santa Sede nei confronti dell’AI generativa.
Discorsi e iniziative: un impegno crescente per un’AI etica
Già nei primi anni del suo pontificato, Francesco ha cominciato a delineare una risposta cattolica alle tecnologie digitali emergenti. In particolare, nel febbraio 2020 – alle soglie della “rivoluzione” dell’AI odierna – il Papa avrebbe dovuto intervenire a un convegno in Vaticano dal titolo emblematico “The Good Algorithm?”. Sebbene impedito da una lieve indisposizione, fece pervenire ai partecipanti un messaggio chiaro: la Chiesa offre la propria riflessione affinché ciò che è automatico rimanga sempre al servizio della persona umana e mai ne leda la dignità. In quella sede il Pontefice coniò anche un neologismo programmatico, parlando di “algor-etica” come di una nuova frontiera in cui costruire un ponte tra valori etici e progettazione algoritmica. I principi della Dottrina Sociale della Chiesa – la dignità della persona, la giustizia, la sussidiarietà e la solidarietà – dovevano, secondo Francesco, inscriversi concretamente nelle tecnologie digitali attraverso il dialogo tra discipline. Solo così l’intelligenza artificiale, dono dell’ingegno umano, può davvero contribuire al bene comune senza tradursi in una minaccia.
Proprio in quei giorni di fine febbraio 2020, dalla collaborazione tra la Pontificia Accademia per la Vita e colossi tecnologici e istituzioni internazionali, nacque un’iniziativa dal forte valore simbolico: la Rome Call for AI Ethics. In occasione del suddetto convegno, il 28 febbraio 2020 presso l’Auditorium di Via della Conciliazione a Roma, venne firmata una “Carta” etica sull’AI alla presenza di esponenti di primo piano. Tra i firmatari figuravano il Presidente della Pontificia Accademia, mons. Vincenzo Paglia, il presidente di Microsoft Brad Smith e il vicepresidente di IBM John Kelly III, affiancati per l’occasione dal Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e dal Direttore Generale della FAO Qu Dongyu. Si trattava – come sottolineò Paglia – di un primo passo per coinvolgere governi e altre grandi aziende nel dibattito avviato. Il messaggio di fondo era netto: “L’umanità usi la tecnologia e non viceversa, perché non sia dittatura dell’algoritmo”. In altri termini, l’algoritmo non deve dominare l’uomo. Questa “Chiamata di Roma” per l’etica dell’AI proponeva principi condivisi – dalla trasparenza all’inclusività, dalla responsabilità all’imparzialità – per orientare lo sviluppo dell’AI in senso umanistico e solidale. Benché non parte del Magistero in senso stretto, la Rome Call rifletteva la volontà della Santa Sede di mettere la centralità della persona umana al cuore della nuova frontiera tecnologica.
La persona al centro: dignità umana, creatività e visione teologica
L’approccio cattolico all’intelligenza artificiale generativa nasce da una visione teologica e antropologica ben definita. Al centro vi è la convinzione che l’essere umano, creato “a immagine di Dio” (Gen 1,27), possieda un’intelligenza e una creatività donate dal Creatore e parte integrante della sua identità spirituale. Questo significa che ogni espressione di creatività tecnica o scientifica – incluso lo sviluppo di algoritmi avanzati – può e deve riflettere la sapienza e la bontà divine, nella misura in cui è orientata correttamente. “Le abilità e la creatività dell’essere umano provengono da [Dio] e, se usate rettamente, a Lui rendono gloria”, afferma un recente documento vaticano. Questa prospettiva positiva vede dunque nella tecnologia un prolungamento della facoltà umana di “coltivare e custodire” il creato (Gen 2,15). L’intelligenza artificiale, frutto dell’ingegno umano, non è in sé un agente dotato di una volontà indipendente, ma uno strumento, un prodotto dell’intelligenza umana. La Chiesa mette in guardia dal considerare “intelligenti” le macchine in senso proprio: “L’uso stesso della parola ‘intelligenza’ riferito alle AI può risultare fuorviante… l’AI non va intesa come una forma artificiale dell’intelligenza umana, bensì come un suo prodotto”. Dietro questa distinzione c’è l’idea che solo l’uomo è persona, dotato di anima razionale e libertà morale, mentre l’algoritmo – per quanto sofisticato – resta privo di coscienza e dipendente dai dati e dai fini impostati dai suoi programmatori.
In questa luce, l’imitazione della creatività umana da parte delle AI generative solleva interrogativi significativi ma non intacca l’unicità della creatività umana. I recenti progressi hanno mostrato come un algoritmo addestrato su immense basi di dati possa generare nuovi “artefatti” creativi – testi letterari, immagini artistiche, perfino musica – con una velocità e abilità tali da uguagliare o superare la capacità di singoli autori umani. Tali prodigi tecnologici, se da un lato stupiscono, dall’altro inducono l’umanità a interrogarsi sulla propria identità. La domanda “cosa significa essere umani?” torna prepotente: qual è il tratto distintivo dell’uomo se una macchina può dipingere un quadro o scrivere una poesia? La risposta implicita della visione antropologica cristiana è che la creatività autentica implica intenzionalità, coscienza, relazione e finalità etica, tutte qualità proprie della persona. Un’AI può emulare l’opera dell’artista, ma non condividerne l’ispirazione interiore; può imitare il linguaggio umano, ma non provare empatia o comprendere davvero il significato come farebbe un soggetto dotato di esperienza vissuta. Pertanto, la Chiesa apprezza i progressi dell’AI come espressione del genio umano, ma ribadisce che la persona deve restare sempre il fine e mai il mezzo di tali progressi. Ogni creatura artificiale, per quanto brillante, rimane ordinata al servizio della creatura umana e del disegno di Dio, non viceversa.
Questa impostazione spiega anche l’insistenza sul concetto di dignità umana. Francesco ha più volte ricordato che la dignità della persona dev’essere il “criterio chiave” per valutare le tecnologie emergenti. Ciò significa che un sistema AI è eticamente accettabile solo nella misura in cui rispetta e promuove la dignità di ogni uomo e ogni donna – specialmente i più vulnerabili – anziché minacciarla. Ad esempio, delegare interamente a un algoritmo giudizi su persone (si pensi al reclutamento del personale, alla concessione di prestiti, o ai sistemi di sorveglianza sociale) rischia di introdurre pregiudizi e discriminazioni se i dati di partenza sono distorti. Non a caso il Papa ha messo in guardia contro l’uso di dati contaminati da preconcetti sociali, che potrebbero condurre a trattamenti iniqui. Ancora, l’illusione di “personalizzare” l’AI – presentando chatbot o robot come se fossero persone – viene giudicata pericolosa, specie per i più giovani: attribuire personalità umana a ciò che è macchina può creare isolamento e fraintendimenti nello sviluppo dei bambini, e addirittura costituire una grave violazione etica se sfruttato per inganno (si pensi a deepfake o a manipolazioni affettive). In tutte queste questioni la bussola della dignità richiede di non perdere mai di vista la centralità dell’umano: la tecnologia deve potenziare le qualità umane (ad esempio aiutare il medico nelle diagnosi senza però sostituire il rapporto umano col paziente e deve ridurre le disuguaglianze anziché aggravare il digital divide o creare una “medicina per i ricchi”. È evidente, dunque, che per il Vaticano la sfida non è solo tecnica ma profondamente morale e culturale: occorre coltivare una “cultura dell’incontro” anche nell’era digitale, ed evitare che prevalga una “cultura dello scarto” potenziata da algoritmi che escludono i deboli.
Dal Vaticano al mondo: dialoghi globali e responsabilità condivise
Coerentemente con questi principi, Papa Francesco ha voluto che il Vaticano fosse non un attore isolato, ma un catalizzatore di dialogo sul futuro dell’AI a livello internazionale. Emblematico è il fatto che esponenti di punta dell’industria tecnologica abbiano trovato nella Santa Sede un interlocutore etico privilegiato. Negli ultimi anni personalità come Brad Smith (Microsoft), Demis Hassabis (Google DeepMind), Sam Altman (OpenAI) ed Elon Musk hanno avuto confronti riservati con il Papa o i suoi rappresentanti. Tali incontri, spesso lontani dai riflettori, indicano che perfino nel cuore della Silicon Valley si guarda alla Chiesa – con la sua tradizione bimillenaria di riflessione sull’uomo – in cerca di orientamento e “confini” morali. Iniziative come i “Minerva Dialogues”, avviati dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione, hanno riunito annualmente a Roma scienziati, imprenditori hi-tech, filosofi ed esponenti ecclesiali in un confronto a porte chiuse, segno di un mutuo interesse tra Vaticano e industria digitale. Francesco stesso ha espresso grande apprezzamento per questo dialogo “inclusivo e serio” sul futuro tecnologico, aperto anche al contributo dei credenti e dei valori religiosi. Nell’udienza ai partecipanti dei Minerva Dialogues del 27 marzo 2023, il Papa ha ribadito la sua fiducia che lo sviluppo dell’AI “possa contribuire in modo positivo al futuro dell’umanità”, a patto che vi sia un impegno costante affinché tale tecnologia resti “human-centred, ethically grounded and directed toward the good” – centrata sull’uomo, radicata nell’etica e orientata al bene. Egli ha accolto con favore il consenso emergente su valori quali inclusione, trasparenza, sicurezza, equità, privacy e affidabilità come principi da rispettare nei processi di sviluppo. Allo stesso tempo non ha nascosto la difficoltà del compito: la nostra “immensa crescita tecnologica non è stata accompagnata da uno sviluppo dell’etica e della coscienza”, ha ammonito citando la sua enciclica Laudato Si’. In ciò risuona la critica al “paradigma tecnocratico”, ossia la tendenza a confidare ciecamente nella tecnica perdendo di vista il fine ultimo dell’uomo e il valore del creato.
Il 14 giugno 2024 il Pontefice è entrato nella storia come il primo Papa ad aver partecipato a un vertice del G7, invitato a rivolgersi ai Capi di Stato e di governo riuniti in Puglia proprio sul tema dell’intelligenza artificiale. Seduto al tavolo dei leader mondiali, tra cui i Presidenti Emmanuel Macron e Joe Biden, Francesco ha lanciato un monito incisivo: “Condanneremmo l’umanità a un futuro senza speranza se sottraessimo alle persone la capacità di decidere su loro stesse e sulla loro vita, condannandole a dipendere dalle scelte delle macchine”. Per questo, ha proseguito, “abbiamo bisogno di garantire e tutelare uno spazio di controllo significativo dell’essere umano sul processo di scelta dei programmi di intelligenza artificiale: ne va della stessa dignità umana”. Parole che riecheggiano con forza il principio già affermato nel 2020: mai dev’essere una macchina a scegliere al posto dell’uomo in ambiti che toccano la vita, la morte, la giustizia. In particolare il Papa, davanti ai potenti della Terra, ha chiesto di bandire le armi letali autonome prima che sia troppo tardi, iniziando subito a imporre un controllo umano significativo sui sistemi d’arma dotati di intelligenza artificiale. “Nessuna macchina dovrebbe mai scegliere se togliere la vita ad un essere umano”, ha dichiarato senza mezzi termini, collegando il discorso sull’AI alla più ampia questione della guerra e della pace. Questo appello non è rimasto isolato: a più riprese Francesco ha invocato l’urgenza di un’azione politica coordinata a livello internazionale sul fronte dell’AI. In un messaggio del dicembre 2023, ad esempio, ha aggiunto la propria voce a chi chiede un trattato globale che assicuri lo sviluppo e l’uso etico dell’intelligenza artificiale, avvertendo che i rischi di una tecnologia priva dei valori umani di compassione, misericordia e giustizia sono troppo grandi per lasciarla priva di regole. Il Papa non è entrato nei dettagli tecnici di un simile accordo, ma ha precisato che dev’essere negoziato a livello mondiale, volto tanto a promuovere le migliori pratiche quanto a prevenire gli abusi. “Le sole aziende tecnologiche non possono essere lasciate a regolarsi da sé”, ha aggiunto con franchezza. Queste prese di posizione collocano il Vaticano tra i protagonisti del dibattito etico globale sull’AI: la voce di Francesco è diventata, secondo alcuni osservatori, un “chiaro appello alla speranza per miliardi di persone” preoccupate per le derive dell’AI. Egli ha contribuito a inquadrare i timori sull’AI nel linguaggio della tradizione intellettuale cattolica, offrendo una prospettiva di speranza ma anche di responsabilità concreta di fronte a quella che ha definito una “vera e propria rivoluzione cognitivo-industriale” in corso.
Va notato, peraltro, che accanto all’azione pubblica si muove una rete di iniziative “dal basso” promosse da realtà cattoliche nel campo dell’AI. La Fondazione OPTIC (Order of Preachers for Technology, Information and Communication), guidata dal domenicano p. Eric Salobir, organizza da anni forum e perfino hackathon vaticani sul tema, coinvolgendo giovani sviluppatori su progetti che coniughino tecnologia e valori sociali. Anche alcune università cattoliche (come la Pontificia Università Lateranense, che ha attivato corsi di “Etica dell’AI”) e singoli studiosi di area cristiana (ad esempio p. Phillip Larrey, docente e consulente in dialogo col mondo tech) stanno contribuendo a elaborare risposte culturali alla sfida dell’AI. Si tratta di tasselli di un mosaico più ampio con cui la Chiesa di Roma tenta di “umanizzare” la tecnologia contemporanea, in sintonia con l’appello di Papa Francesco a un’“algoretica” condivisa e interdisciplinare.
Verso il futuro: come potrà evolvere l’atteggiamento della Chiesa con un nuovo pontefice?
Guardando avanti, è lecito domandarsi come un futuro Papa potrà proseguire o innovare l’approccio di Francesco all’intelligenza artificiale generativa e ai grandi modelli di linguaggio. Quali scenari si delineano? Molto dipenderà dalla personalità, dalle priorità pastorali e dal retroterra culturale del prossimo pontefice – elementi che influenzeranno il suo sguardo sulle questioni tecnologiche. Un primo possibile scenario è quello della continuità e dello sviluppo. Se venisse eletto un Papa sensibile ai temi sociali e globali in linea con il percorso tracciato (si pensi a cardinali considerati papabili come l’asiatico Luis Antonio Tagle o l’italiano Matteo Zuppi, entrambi attenti al dialogo con il mondo contemporaneo), con ogni probabilità verrebbe confermato l’impegno del Vaticano nell’ambito dell’AI etica. Anzi, questo impegno potrebbe persino intensificarsi: il nuovo pontefice potrebbe ad esempio promulgare un’enciclica o un documento magisteriale specifico sulla fraternità digitale e l’uso giusto dell’intelligenza artificiale, integrando i principi già espressi da Francesco in un più organico insegnamento sociale. Si tratterebbe di raccogliere l’eredità di iniziative come la Rome Call for AI Ethics, verificandone i frutti, e magari di promuovere nuove forme di collaborazione internazionale. Un Papa proveniente da contesti dove forte è il divario tecnologico (ad esempio dall’Africa o dall’Asia) potrebbe inoltre insistere sul tema dell’equità nell’accesso alle tecnologie, affinché l’AI non accresca le disuguaglianze tra Nord e Sud del mondo ma diventi semmai strumento di sviluppo sostenibile. In continuità con Francesco, verrebbe mantenuto vivo anche il dialogo con scienziati e imprenditori: la Santa Sede potrebbe farsi promotrice di un forum permanente su etica, religioni e AI, coinvolgendo non solo il cristianesimo ma anche altre fedi (come già visto nell’adesione di leader islamici, ebraici e di altre religioni alla Rome Call). Questo scenario di continuità vedrebbe insomma la Chiesa consolidare il suo ruolo di coscienza critica nella rivoluzione digitale, con una presenza costante nei dibattiti pubblici – dai consessi dell’ONU ai tavoli di lavoro col settore privato – per assicurare che la voce dei valori umani e trascendenti non sia soffocata dal rumore dell’innovazione.
D’altra parte, non si può escludere uno scenario di approccio più cauto o differente nelle enfasi con l’avvento di un nuovo pontefice. La storia dei papi mostra che ognuno porta sensibilità peculiari: un Papa con formazione più tradizionale o concentrato su questioni dottrinali potrebbe scegliere di dedicare meno attenzione diretta al tema dell’AI, senza naturalmente smentire il magistero precedente ma magari integrandolo in un discorso più ampio sui pericoli della secolarizzazione o della perdita di senso del sacro. In tal caso, l’accento potrebbe spostarsi maggiormente sulla denuncia dei rischi spirituali legati alla tecnologia: per esempio, un pontefice di orientamento conservatore potrebbe mettere in guardia contro una sorta di “idolatria della tecnoscienza”, ribadendo con forza che la salvezza dell’uomo non verrà mai da un algoritmo onnipotente ma solo da Dio. Potrebbe richiamare l’attenzione sui pericoli del transumanesimo estremo, ossia l’idea di migliorare o sostituire l’essere umano mediante la tecnica, giudicandolo incompatibile con l’antropologia cristiana. Ciò non significherebbe affatto un ripudio della tecnologia (la Chiesa, anche nei pontificati più prudenti, non ha mai rifiutato il progresso scientifico in sé), ma forse una minore enfasi su partnership con aziende e una maggiore enfasi sul discernimento morale dei fedeli nell’uso quotidiano degli strumenti digitali. Un Papa più riservato su questi temi potrebbe lasciare maggior spazio alle Accademie pontificie e ai dicasteri vaticani di competenza (come Dottrina della Fede, Cultura e Educazione, o lo stesso dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale) affinché continuino il lavoro, intervenendo lui stesso solo in occasioni mirate. Questo scenario vedrebbe comunque la Chiesa proseguire sulla rotta tracciata, ma forse con toni meno profetici e più improntati alla prudenza pastorale, integrando il discorso sull’AI in una catechesi più ampia sui valori umani nell’era digitale.
Infine, si può immaginare anche uno scenario intermedio, in cui il nuovo Pontefice unisca continuità e nuovi accenti. Ad esempio, un Papa proveniente dall’America Latina con forte sensibilità per la pastorale urbana e i media potrebbe collegare la questione dell’AI al tema della comunicazione e dell’evangelizzazione: utilizzando i grandi modelli linguistici come strumento per diffondere il Vangelo (sempre con il dovuto discernimento), ma al contempo ammonendo sui pericoli della disinformazione e delle fake news potenziate dall’AI. Un Papa gesuita intellettuale, sulla scia di Paolo VI o Benedetto XVI, potrebbe elaborare una più approfondita teologia della tecnologia, aiutando i fedeli a vedere nell’AI non solo un problema etico, ma anche un’occasione per ripensare la condizione umana nell’orizzonte della Provvidenza divina. In ogni caso, qualsiasi Pontefice che dovesse guidare la Chiesa nei prossimi decenni non potrà eludere le sfide poste dall’AI generativa: troppo pervasiva sarà diventata nella società e nell’economia globale. È dunque verosimile che, pur con stili e priorità differenti, la Santa Sede continuerà a tenere alta l’attenzione morale su questo fronte. Come affermato da commentatori vicini al Vaticano, la Chiesa è chiamata a un ruolo “profetico” nell’era dell’AI – un ruolo che consiste sia nel nutrire visioni di speranza sul contributo positivo che la tecnologia può dare all’umanità, sia nel denunciare con franchezza i mali presenti, dalle ingiustizie sociali alle derive disumanizzanti.