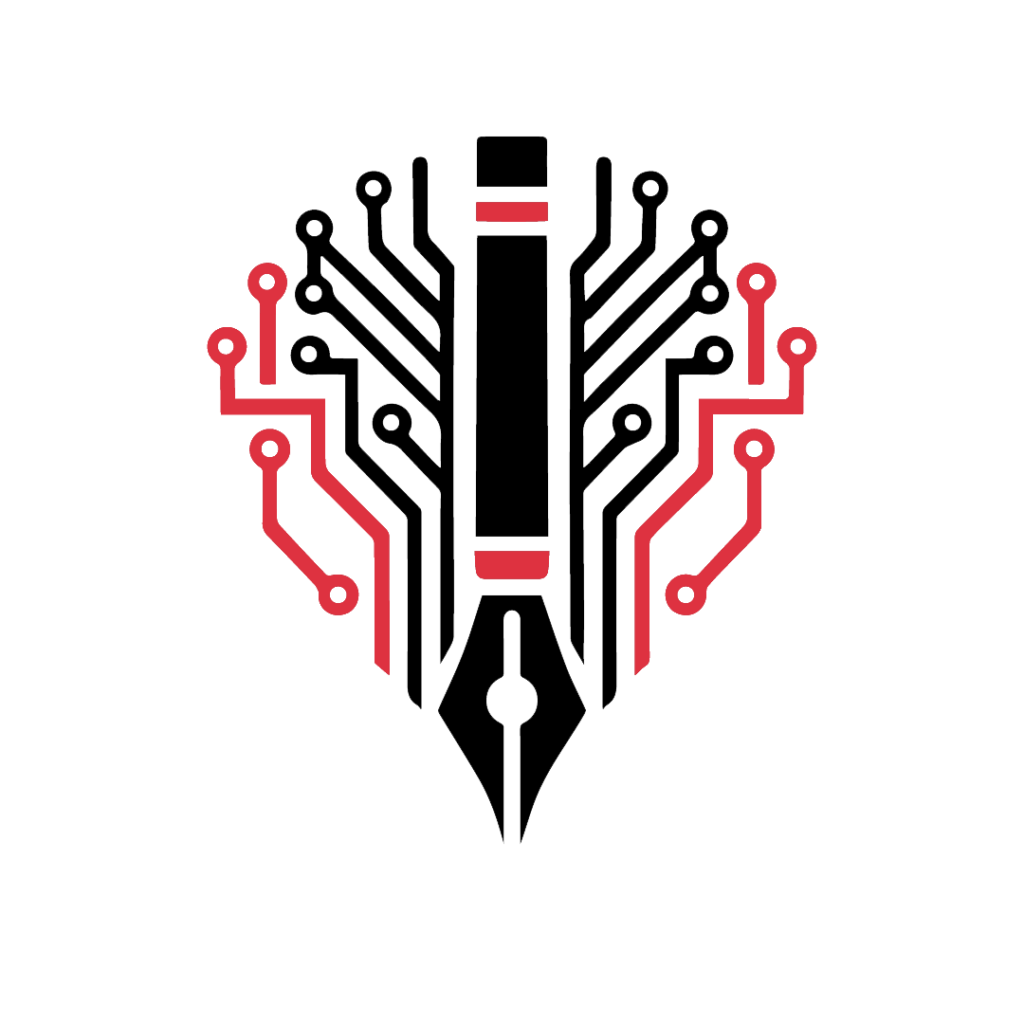
Quest’opera contiene in larga parte contenuti generati dall’intelligenza artificiale (GPT-4.5). L’intervento umano è stato centrale nello sviluppo della trama, nella revisione e nella cura del prodotto finale. Edizione 1.0 © 2025
1
L’autunno la investì, un’onda gelida che l’avvolse appena scese dall’auto. Non era il solito ottobre ancora caldo degli ultimi anni: l’aria era una corrente umida, intrisa di foglie morte, capace di insinuarsi nelle ossa con la forza di una premonizione.
Via dei Tigli. Il numero 14. La villetta apparve più piccola, consunta, implorante. Sembrava un corpo agonizzante, schiacciato sotto il peso di un’angoscia invisibile. E quel silenzio… denso, immobile, una pressione sui timpani che sfiorava il dolore. Sua madre. Il pensiero restava muto, come soffocato da un’assenza troppo grande. Non un nome, ma un grido tagliente.
Le chiavi, fredde nella mano, avevano il peso di un rito antico. La serratura oppose resistenza, quasi a rifiutare il suo ingresso. Poi, uno scricchiolio secco, più strappo che cigolio. L’odore che la accolse non era solo quello di polvere o di aria ferma; c’era altro, qualcosa di più antico, viscerale, che le strinse la gola.
La luce, giallastra e opaca, non illuminava davvero: rendeva tutto più sporco, più vecchio. L’ingresso non lo vide con chiarezza, ma ne avvertì il peso: anni sedimentati nell’aria, echi di passi estranei che sembravano ancora risuonare tra le pareti. Ogni respiro divenne un atto di coraggio. Davanti a lei, il corridoio si allungava come un tunnel, pronto a inghiottirla.
Le stanze erano frammenti dispersi di qualcosa andato distrutto molto tempo prima. La cucina, il salotto, la lavanderia, luoghi freddi e opprimenti, ferite sottili di assenza che colpivano in profondità.
Infine, la porta della sua stanza. Un buco nero, un limite oltre il quale non c’era ritorno. Non la guardò, la sentì. Un brivido incontrollabile le risalì la schiena. Non era freddo. Era disagio puro. La mano tremava. Non era paura del luogo. Era qualcosa che risiedeva in lei da sempre, in agguato nelle pieghe della sua coscienza. Poi le parole, incise con rabbia nel legno scuro, come una ferita aperta:
«È ancora dentro di te.»
Non un messaggio, un monito.
Un promemoria di qualcosa di irrisolto, pronto a riemergere.
Quelle parole risuonavano nella mente di Eleonora con una chiarezza inquietante, amplificate dal silenzio pesante che riempiva ogni angolo della casa. Non era un ricordo definito, bensì una sensazione persistente, un’ombra silenziosa che le scavava dentro.
Cercò di respirare lentamente, contando i battiti accelerati del cuore, un tentativo disperato di mantenersi ancorata alla realtà. Ma quale realtà? Quella fatta di ombre sfuggenti e presenze impalpabili o quella costruita fuori, lontano da lì, fragile illusione pronta a frantumarsi?
Si passò una mano sul viso. La pelle era fredda e umida sotto le dita. Tremava. Non per il freddo di ottobre, ma per un brivido più profondo, interno, che risaliva dalle viscere. Un disagio inespresso, inquietante, ancora privo di nome.
Si sforzò di osservare la porta, non solo percepirla: il legno scuro, consumato, segnato dal tempo e da qualcosa di più oscuro. Quelle parole incise con rabbia e disperazione. Chi le aveva scritte? Sua madre? E cosa volevano dirle davvero?
Un altro brivido le percorse la schiena. Non era sola. Percepiva qualcosa, una presenza sottile eppure pesante, che aleggiava attorno a lei, silenziosa, inesorabile. Non minacciosa, non ancora. Ma presente. Inevitabile. Le gravava addosso, le impediva di respirare a fondo. Era il passato? Il ricordo della madre? Oppure qualcosa dentro di lei, nascosto, trascurato da troppo tempo?
Fece un passo indietro, istintivamente, sperando di sottrarsi a quella sensazione opprimente. Il corridoio dietro di lei si allungò, si strinse, la spinse contro le pareti invisibili di un incubo. Ogni ombra un’accusa silenziosa. La frase continuava a pulsarle in testa, insistente, ossessiva: «È ancora dentro di te».
Doveva andarsene. Subito. Eppure non riusciva a muoversi, radicata al pavimento da qualcosa di più forte della paura: l’incapacità di affrontare ciò che portava dentro. Qualcosa che ancora non sapeva definire.
2
La luce del mattino, filtrata dalle persiane chiuse, la raggiunse con delicatezza, quasi a volerla scuotere dolcemente dal torpore. Eleonora aprì gli occhi, fissando il soffitto della stanza degli ospiti, la mente ancora intrappolata in un dormiveglia carico di inquietudini senza volto. Casa di Andrea, suo fratello: un rifugio, almeno in apparenza. Anche i luoghi sicuri possono nascondere crepe profonde.
Si sollevò lentamente dal letto, provando la pesantezza di chi ha attraversato una notte agitata, combattendo contro ombre che non si rivelano. Lo specchio le restituì un’immagine che faticava a riconoscere: pallida, stanca, con ombre scure sotto gli occhi. Non era la donna che viveva a Milano, lontana e sicura. Era una figura indefinita, consumata da un senso di disagio che non riusciva ancora a comprendere.
L’aroma del caffè la richiamò al piano inferiore. Andrea era già lì, in cucina, la figura robusta china sul tavolo. Portava il peso degli anni e del dolore con una dignità diversa dalla sua, forse semplicemente più rassegnata.
«Buongiorno», disse lui con voce rauca, senza alzare lo sguardo.
Eleonora annuì appena, incapace di articolare una risposta. Si sedette lentamente, sentendo la rigidità della sedia e il freddo del legno sotto le mani.
«Oggi la chiudono», continuò Andrea, le parole faticavano a uscire, spezzate dall’emozione. «La bara, intendo. Ci aspettano alla sala del commiato.»
Eleonora restò in silenzio, senza provare qualcosa di chiaro, solo una sensazione di vuoto che la stringeva dentro. E ancora quelle parole, quel monito ostinato che non la abbandonava: «È ancora dentro di te».
«Non so se ce la faccio», mormorò infine, rivelando una fragilità che la turbava profondamente.
Andrea si avvicinò, appoggiando delicatamente le mani grandi e calde sulle sue spalle, un gesto di conforto semplice, familiare. «Ci sono io, Ele. Non sei sola.»
Quel “non sei sola” suonò stranamente distante, quasi irreale. Chi erano davvero, loro due, oltre al lutto che li univa e al passato che pesava sulle loro spalle? Chi era lei, in mezzo a tutto questo? La risposta sfuggiva, si perdeva in una nebbia interiore che ancora non riusciva a dissolvere. La chiusura della bara non era una fine, ma un inizio: quello di una necessaria resa dei conti con sé stessa, con ciò che aveva lasciato indietro, con ciò che portava dentro, ancora senza nome ma già palpabile come un’ombra silenziosa e inevitabile.
3
La pioggia leggera, quasi una nebbia, accompagnò Eleonora durante quel pomeriggio di esequie, avvolgendola in una sospensione rarefatta, simile a quella delle lunghe notti passate davanti agli schermi, immersa in grafici e dati complessi, mentre consumava lentamente la sua sigaretta elettronica. Era il suo lavoro da ricercatrice oltre che la sua ossessione: esplorare il territorio incerto dell’inconscio digitale, cercando correlazioni tra i sogni umani e le fasi “oniriche” delle intelligenze artificiali evolute, ormai capaci di simulare complesse manifestazioni emotive.
Ora, adulta e scienziata in cerca di affermazione, Eleonora continuava a inseguire quelle risposte elusive. Le lunghe notti trascorse in laboratorio, studiando i “sogni” artificiali, erano un modo per comunicare attraverso quel filo invisibile che lega il sogno alla realtà, l’umano al digitale.
Un flash improvviso, un’immagine vaga emersa dal passato. Aveva quindici anni, forse sedici. Capelli neri tinti, la frangia lunga che nascondeva occhi pesantemente truccati, un look fatto di borchie, catene e rabbia adolescenziale. Lyra, così aveva scelto di chiamarsi. Ricordava le interminabili discussioni con sua madre, il fiume impetuoso di parole sul dolore, sull’amore non compreso, sulla sofferenza ostentata con tragica enfasi. Sua madre, seduta sul divano con il capo avvolto in un foulard, nascondendo la perdita di capelli causata dalla chemio, la osservava con pazienza e un lieve sorriso triste.
«Lyra, cara mia, la sofferenza vera non la conosci ancora, per fortuna. Ora parli di morte e dolore come fossero concetti astratti.»
Eleonora ricordava la rabbia di allora, l’indignazione, la certezza di non essere capita da nessuno, neanche da sua madre. Gridava che lei non poteva comprendere, che nessuno avrebbe mai potuto.
L’immagine svanì lentamente, lasciando spazio alla realtà brutale di quel momento: la bara aperta davanti ai suoi occhi, il volto di sua madre ormai sereno e distante, libero finalmente dal dolore fisico che aveva combattuto due volte. La prima, durante l’adolescenza di Eleonora, era riuscita a superarla. La seconda, arrivata molti anni dopo, in un tempo in cui tra loro era calato un silenzio profondo, era stata definitiva. Ora Eleonora capiva, con un’amara consapevolezza, che le sue parole adolescenziali erano state prive di peso, superficiali di fronte al vero dolore vissuto da sua madre.
Quel confronto, ora impossibile, la colpì con un’ondata di rimorso tardivo. Sua madre aveva avuto ragione, sempre. Aveva combattuto davvero, non contro fantasmi creati dalla mente, ma contro un nemico reale, fisico e tangibile. Eleonora provò un dolore acuto, una fitta di rimpianto per non aver mai potuto dire a sua madre che aveva compreso, che aveva sbagliato. Tutto ciò che restava ora era quell’avvertimento enigmatico, inciso sul legno e dentro la sua anima: «È ancora dentro di te».
Il primo gesto fu quasi rituale: l’impiegato, con gesti precisi e delicati, sistemò il velo sul volto di sua madre. Eleonora sentì la gola stringersi. Rimase immobile, distante, senza avvicinarsi alla salma nemmeno per un ultimo tocco o un saluto ravvicinato. Un altro flash improvviso le attraversò la mente: sua madre giovane e piena di vita che le sistemava il colletto della camicia prima di una giornata importante a scuola, il tocco lieve delle dita, il profumo familiare della sua pelle, un senso di sicurezza che ora le sembrava lontanissimo. L’immagine sfumò rapidamente, sostituita da un’altra: sua madre in ospedale, il volto pallido e scavato, le mani fragili che cercavano le sue.
Poi venne il coperchio, lento e definitivo, che calava separando irreversibilmente il mondo dei vivi da quello dei morti. Vide le mani guantate dell’impiegato guidare con cura il legno scuro. Un altro ricordo, violento questa volta: una lite furiosa, parole taglienti come lame che ancora ora le riecheggiavano dentro senza che potesse ricordarne il contenuto esatto, solo la rabbia che le aveva animate.
Iniziarono ad avvitare. Ogni giro di vite le trasmetteva un suono stridente, metallico, penetrante. E ad ogni giro, un frammento di ricordo tornava a galla: istantanee sbiadite di tenerezza e conflitti, sua madre fragile ma combattiva, sua madre emozionata il giorno della sua laurea, sua madre delusa, che le gridava qualcosa che ora non riusciva a decifrare.
L’ultimo giro e la bara fu sigillata. Definitivamente, irrevocabilmente. In quel momento la colpì il pensiero più chiaro e doloroso di tutti: la telefonata che non aveva mai fatto. Eleonora era stata lontana, irraggiungibile, assente. Ora era troppo tardi per tutto.
Gli impiegati si allontanarono, lasciando Eleonora e suo fratello soli di fronte a quella bara chiusa per sempre. Conteneva più del corpo della madre: racchiudeva un passato irrisolto, pieno di cose non dette e occasioni perdute, e quell’avvertimento persistente, inciso sulla porta e nella sua anima.
Un altro lampo dal passato la raggiunse improvviso: Lyra, curva su un quaderno fitto di sogni e visioni confuse, cercando di interpretare ciò che sembrava indecifrabile. Sua madre, indebolita, la osservava silenziosa, con preoccupazione velata da curiosità. «Cerchi risposte dove non ce ne sono», diceva a volte con voce stanca, senza ottenere risposta.
4
La luce opaca del sole filtrava a stento attraverso le tende della cucina, illuminando polvere sospesa e silenzi pesanti. Eleonora e Andrea erano seduti al tavolo, ciascuno con una tazza di caffè ormai freddo davanti, avvolti da una quiete piena di parole non dette. Si trovavano nella casa della madre, un luogo che Eleonora sentiva di non poter lasciare, non ancora.
«Dobbiamo venderla» disse Andrea, rompendo quel silenzio carico di tensione. La voce gli tremò appena, tradendo l’emozione e la stanchezza accumulata in quei giorni.
Eleonora annuì lentamente, senza guardarlo. Vendere la casa significava affrontare ricordi, perdite, rimorsi. Un atto necessario ma doloroso, che le sembrava quasi un tradimento.
«Io devo andare» continuò Andrea, la voce ancora più bassa. «Mia moglie ha bisogno di me. Sua madre non sta bene.»
Eleonora avvertì una stretta al petto. La sua assenza in passato, il rimorso, la colpa che non riusciva a lasciarla.
«Me ne occupo io» disse alla fine, con una fermezza che stupì lei stessa. Non era una proposta, era una decisione, forse un tentativo di redenzione, di non ripetere gli stessi errori.
Andrea la guardò, gli occhi lucidi e sollevati. «Sei sicura? Tu hai il tuo lavoro…»
«Sì, me ne occupo io,» ripeté Eleonora con calma determinata. Andrea annuì, un sorriso grato e stanco sul volto. Si alzò lentamente e si avvicinò per un abbraccio breve ma sincero. Poi si allontanò, lasciandola sola con quel compito difficile. Vendere la casa non significava solo sistemare questioni economiche, ma anche affrontare sé stessa, ciò che aveva lasciato sospeso, ciò che ancora viveva lì dentro, tra quelle mura. Una realtà che non poteva più evitare.
5
L’indomani il camion della ditta di sgombero arrivò insieme al furgone dell’università, creando un contrasto netto e surreale tra ciò che veniva portato via e ciò che invece veniva introdotto nella casa. Da una parte, operai rozzi smontavano mobili, riducevano a pezzi oggetti che avevano costituito una vita intera. Sedie rotte, scaffali svuotati, fotografie private delle cornici: ogni cosa veniva spezzata, ammucchiata senza cura, caricata su camioncini anonimi, pronta a essere dimenticata altrove.
Dall’altra parte, con movimenti precisi e attenti, gli assistenti del laboratorio scaricavano sofisticate attrezzature scientifiche: diversi monitor, server compatti, delicati sensori avvolti in imballaggi protettivi. Eleonora osservava tutto questo, colta da una sensazione straniante, quasi ipnotica. Era come assistere allo scontro tra due mondi opposti, inconciliabili. Uno precipitava irreversibilmente nel passato, l’altro si imponeva con freddezza tecnologica, rivolto a un futuro che non contemplava nostalgia.
Aveva deciso di continuare parte della sua ricerca proprio lì, nella casa della sua infanzia, mentre aspettava che fosse venduta. Con un gesto rapido, fece cenno agli assistenti di seguirla verso quella che era stata la sua camera. Là dentro, tempo prima, aveva vissuto un’adolescenza tormentata, carica di diari, poesie oscure, vestiti neri e fotografie consumate dalle lacrime e dalla rabbia. Ora, quello stesso luogo si sarebbe trasformato in un laboratorio remoto, nel cuore pulsante di una ricerca complessa: l’esplorazione di un possibile “inconscio artificiale”, ossia l’insieme spontaneo e simbolico di dati generati da intelligenze artificiali avanzate, quando lasciate operare in condizioni di apprendimento non supervisionato.
Mentre osservava i tecnici collegare cavi e installare i monitor luminosi, la frase incisa nella porta della stanza, ora nascosta dietro i pannelli metallici e le luci dei nuovi strumenti, continuava a risuonarle nella mente: «È ancora dentro di te». Quelle parole non erano semplicemente una traccia sbiadita del passato. Era come se la casa stessa avesse intuito ciò che Eleonora stava facendo: cancellare fisicamente i ricordi, rimpiazzarli con qualcosa di artificiale, forse per trovare una risposta razionale e scientifica al proprio disagio interiore.
La casa, svuotata dei mobili e contemporaneamente riempita di nuove macchine, diventava il simbolo perfetto della lotta che Eleonora stava vivendo: il tentativo impossibile di anestetizzare ricordi dolorosi attraverso la freddezza dei dati, di trasformare sogni in simboli calcolabili. Eppure, sentiva con inquietudine che il passato non sarebbe mai andato via davvero. Sarebbe rimasto lì, dentro di lei, racchiuso nell’inconscio, custodito e forse amplificato dalle stesse macchine che avrebbe usato per decifrarlo. Proprio come aveva suggerito quella frase, così semplice e così profondamente vera.
6
Col passare delle settimane, la casa divenne sempre più simile a un organismo, qualcosa di caotico, cresciuto senza alcun controllo apparente. Eleonora aveva iniziato portando poche e ordinate apparecchiature nella sua stanza, ma ora i monitor, i server e le nuove strumentazioni invadevano stanze adiacenti, corridoi, ogni angolo disponibile. Decine di cavi scorrevano lungo il pavimento come radici impazzite, annodandosi in matasse intricate, impossibili da seguire. Le luci intermittenti delle macchine proiettavano strane ombre e riflessi che si inseguivano lungo le pareti spoglie.
La vendita della casa era divenuta un dettaglio lontano, un’operazione che procedeva al rallentatore, quasi dimenticata. Le chiamate dell’agente immobiliare rimanevano senza risposta, e i documenti giacevano abbandonati sotto pile disordinate di appunti scientifici. Eleonora aveva smesso deliberatamente di uscire, intrattenendo al massimo qualche breve comunicazione fatta di brevi messaggi. Quella solitudine era ormai la sua unica protezione dal dolore, dal passato.
Una sera, dopo una pioggia insistente durata ore, Eleonora notò che in alcuni punti del pavimento si era raccolta dell’acqua piovana, penetrata da vecchie infiltrazioni dimenticate. Non era abbastanza da minacciare le macchine, ma sufficiente a creare superfici riflettenti che amplificavano le luci fredde e intermittenti degli strumenti elettronici. Quei riflessi immobili e surreali aggiungevano un ulteriore strato di inquietudine, specchi distorti che rimandavano una realtà confusa e frammentata.
Nel cuore di questo ambiente pulsante, caotico e umido, Eleonora era sempre più consapevole che la sua ricerca stesse andando oltre l’originale natura scientifica. Non poteva più ignorare che ciò che stava studiando non fosse del tutto separato da lei.
Secondo la sua teoria, sviluppata nel corso di anni di studio, le AI, lasciate operare in ambienti privi di guida o finalità dichiarate, tendevano a generare flussi di contenuto spontaneo: associazioni visive, metafore testuali, sequenze simboliche che richiamavano da vicino la logica frammentaria e caotica del sogno umano. Lei trascorreva ore a esaminare quei dati, incrociandoli con le scansioni cerebrali raccolte da soggetti umani in fase REM, nella speranza di trovare corrispondenze, schemi ricorrenti, connessioni latenti. A tratti, sembrava davvero di esplorare una zona grigia tra coscienza e calcolo, una frontiera in cui la mente umana e quella algoritmica iniziavano ad assomigliarsi.
La sua era una ricerca rischiosa, ai confini della neuroscienza, dell’intelligenza artificiale e della psicologia. Gran parte delle sue sperimentazioni più avanzate non erano note al team di ricerca e restavano confinate a uno studio personale. L’ipotesi più audace su cui stava lavorando prevedeva un’integrazione attiva tra questi modelli simbolici e alcune interfacce neurali sperimentali, già utilizzate in ambito medico. L’obiettivo era ambizioso: istruire l’AI affinché potesse riconoscere e sigillare artificialmente ricordi traumatici, impedendo che riaffiorassero nella coscienza e compromettessero la stabilità psichica del soggetto.
Ma c’era un ostacolo fondamentale. Sebbene le AI avessero dimostrato una sorprendente capacità nel riconoscere e ricostruire ricordi perduti in pazienti affetti da diverse patologie neurologiche, nessun algoritmo è in grado di replicare la facoltà umana di rimuovere quelli traumatici. Il cervello, a volte, attiva un meccanismo di difesa così profondo da rendere il ricordo del tutto inaccessibile alla coscienza. Ed è proprio quel processo che Eleonora non riesce a simulare nei suoi modelli. Per comprenderlo, deve osservarlo nel momento in cui fallisce: quando il ricordo riemerge con violenza, rompendo il sigillo protettivo dell’inconscio. Solo in quel punto critico si può cogliere il funzionamento, o il cedimento, del meccanismo stesso. Ma questo significa costringere un essere umano a rivivere l’indicibile, cosa molto diversa dagli studi fatti in precedenza.
Ed è lì che nacque la deviazione. Di fronte all’impossibilità di testare il sistema su altri, cominciò a considerare la possibilità più estrema: usare sé stessa come caso clinico. Da tempo avvertiva, sotto la superficie del lavoro scientifico, una pressione crescente. Qualcosa dentro di lei sembrava volersi manifestare, qualcosa che la mente cosciente aveva escluso, sigillato anni prima. E forse proprio per questo, pensò, il suo subconscio rappresentava il terreno ideale su cui testare l’esperimento.
L’interfaccia neuro-ottica impiantata alla base del cranio, installata anni prima per motivi sperimentali, era ancora perfettamente operativa. Le consentiva di collegarsi ai dispositivi con grande precisione, trasmettendo e ricevendo impulsi neurali e flussi di dati in tempo reale. In precedenza, l’aveva usata solo per test controllati e sicuri, utilissimi per la sua ricerca. Ma ora, quella tecnologia si preparava a diventare la chiave d’accesso a una regione fragile e sconosciuta.
7
Eleonora sedeva immobile davanti allo schermo, la stanza immersa nel silenzio interrotto solo dal sommesso brusio delle apparecchiature elettroniche. Era notte fonda, ma non avrebbe saputo dire con certezza da quanto tempo fosse lì seduta, assorta nei pensieri che scorrevano incessanti, aggrovigliati quanto i cavi sparsi ai suoi piedi. Le luci dei monitor pulsavano ritmicamente, riflettendosi debolmente sulla superficie lucida del sottile connettore neuro-ottico che teneva tra le dita, un piccolo dispositivo trasparente che scintillava debolmente alla luce, apparentemente innocuo, eppure carico di promesse e minacce allo stesso tempo.
Ma ciò che Eleonora stava per fare in quel momento non era parte delle ricerche che aveva presentato in convegni o discusso con colleghi. Quelle erano solo le premesse accademiche, la superficie razionale del suo lavoro. Al di sotto, da tempo, coltivava segretamente un obiettivo diverso, più profondo e pericoloso, che non poteva ancora divulgare. La ricerca ufficiale sulle intelligenze artificiali e il loro subconscio digitale era la porta d’accesso; ora Eleonora era pronta ad attraversare quella soglia e portare la sperimentazione direttamente dentro di sé.
Chiuse gli occhi per un lungo istante, ascoltando il battito irregolare del suo cuore. Nel silenzio della stanza, riusciva quasi a percepire fisicamente il peso di ciò che aveva sepolto. Aprì lentamente gli occhi, posizionò con decisione il piccolo connettore neuro-ottico nel dispositivo alla base del cranio, sentendo immediatamente una lieve pulsazione luminosa attraversarle la testa. Un brivido le percorse la schiena, freddo e insieme liberatorio. Gli schermi davanti a lei si accesero, le curve degli impulsi cerebrali iniziarono a oscillare come onde su uno spettro luminoso, mentre i flussi si allineavano ai pattern neurali artificiali.
In quel preciso istante, Eleonora capì che non sarebbe più potuta tornare indietro. Aveva aperto la porta, aveva permesso al passato di uscire dalla prigione in cui era stato confinato per anni. E ora, inevitabilmente, sarebbe riemerso con tutta la forza del ricordo, della verità e del dolore.
8
Lui era arrivato all’improvviso, come un ospite di passaggio che poi non se ne va più. La madre lo presentò come un amico di vecchia data, qualcuno che avrebbe potuto dare una mano in casa mentre lei affrontava le cure. Suo padre se n’era andato anni prima, con discrezione, lasciando dietro di sé solo silenzi e un cognome. La separazione non era mai stata formalizzata in un vero divorzio: era rimasta una ferita aperta, mai cicatrizzata del tutto, come se tutti avessero preferito fingere che non fosse mai accaduta.
Il nuovo compagno si chiamava Claudio, ma Eleonora non lo chiamava quasi mai per nome. Era semplicemente “lui”. Più giovane della madre, ma non abbastanza da sembrare fuori posto. Non aveva l’aria di un uomo instabile, né quella di un patrigno affettuoso. Era silenzioso, misurato, a tratti premuroso. Parlava poco, ma la osservava molto. All’inizio, Eleonora non capiva se fosse disagio o semplice curiosità. Poi cominciò a notare i dettagli: lo sguardo che indugiava qualche secondo di troppo, la porta che si chiudeva con lentezza dietro di lei, i gesti gentili carichi di un’attenzione che non aveva mai ricevuto da un adulto maschio.
Nel contesto di quella casa che odorava di disinfettante e paura, di notti insonni e vomito da chemioterapia, Eleonora cominciò a vivere un doppio tempo. Da una parte, c’era la figlia che cercava di fare la sua parte: aiutava come poteva, studiava, provava a restare a galla. Dall’altra, un’adolescente disorientata, incerta, affascinata da quell’attenzione silenziosa che le veniva rivolta da Claudio. Una presenza maschile che non aveva mai veramente conosciuto, che colmava spazi vuoti con una naturalezza inquietante.
Non fu improvviso. Nessuno dei due lo avrebbe mai descritto come un evento. Fu una progressione, fatta di piccoli scarti nella quotidianità, di confini che si spostavano lentamente, giorno dopo giorno. Le mani che si sfioravano nella cucina silenziosa, i silenzi troppo lunghi quando si incrociavano nei corridoi. Una carezza sulla schiena che restava, che non si staccava subito. Non ci furono parole, né promesse. Solo il vuoto che si riempiva di gesti, e la solitudine che cercava sollievo dove non avrebbe dovuto trovarlo.
In quelle settimane Eleonora non si sentì mai una vittima. Sentirlo adesso, con il senno di poi, le faceva paura. Allora non provava paura. Provava sollievo, forse perfino una forma confusa di amore. Un amore malato, deviante, ma che sembrava l’unica cosa viva in una casa piena di malattia e rassegnazione.
Non raccontò mai nulla a nessuno. Neanche quando cominciò ad avere dubbi. Neanche quando, nel cuore della notte, si alzava e andava in bagno per contare i giorni sul calendario. Il pensiero che qualcosa potesse nascere da quel rapporto le si annidava dentro come un tarlo. Eppure taceva. Claudio taceva. Tutto continuava a scorrere come se nulla fosse accaduto. Ma qualcosa era cambiato, profondamente. E nulla sarebbe più tornato come prima.
Per l’Eleonora adulta, non si trattava semplicemente di eventi dimenticati: erano ricordi sigillati da blocchi profondi, murati con una precisione quasi chirurgica. E fu proprio l’esperimento in corso a rompere quei sigilli. L’AI, allenata su pattern simbolici generati sia dai sogni umani che dai cicli onirici delle reti neurali, aveva iniziato a generare immagini disturbanti, disarticolate ma familiari, capaci di risvegliare ricordi rimossi con violenza. Non visioni chiare, ma indizi. La forma di una mano su un vetro appannato, un rumore ovattato dietro una porta, la sequenza ripetitiva di una carezza.
Ogni frammento che l’algoritmo restituiva sembrava risuonare con una parte dimenticata del suo corpo. L’intelligenza artificiale, con la sua logica aliena, stava sondando proprio le profondità che la coscienza umana aveva preferito evitare. Quella che era iniziata come un’indagine teorica stava diventando un’immersione emotiva, un’evocazione programmata e inarrestabile del dolore sepolto. E in quell’evocazione, Eleonora iniziava a intravedere una verità che non poteva più ignorare.
Il confine tra realtà e memoria, tra presente e passato, cominciava a cedere. Eleonora sentiva la barriera che proteggeva il suo io conscio vacillare sotto l’effetto combinato dell’esperimento e della solitudine assoluta in cui era sprofondata. L’intelligenza artificiale con cui stava lavorando, progettata per esplorare i sogni digitali e gli spettri dell’inconscio, stava scavando in profondità con un’efficacia che lei stessa non aveva previsto. Ogni sessione sembrava portare a galla simboli, immagini e sequenze che non appartenevano solo alla macchina, ma a lei.
Fu durante una di queste sessioni notturne che accadde. Una frase emersa dallo schermo, tra stringhe di dati e grafici in mutazione. Non era stata generata consapevolmente: era solo… comparsa. Una citazione, un frammento, qualcosa di sepolto. «Questo schifo ti resterà dentro.» Una scarica elettrica le attraversò il corpo. Quelle parole. Le aveva già sentite. Le aveva sentite gridare.
Il ricordo si schiuse come un uovo rotto, colando fuori denso, vischioso, inarrestabile.
Dalla terapia, sua madre era rientrata prima del previsto. Non ricordava se fosse stata una svista, un’imprudenza, o solo il punto esatto in cui le cose dovevano rompersi. Ma vide. Vide i messaggi sul cellulare. Non serviva molto per capire: allusioni, numeri di giorni, battute maldestre. Il sospetto era evidente: Eleonora temeva di essere rimasta incinta. E Claudio rispondeva con parole ambigue, mezze rassicurazioni, mezze promesse.
La madre non urlò subito. Per un istante rimase immobile, il viso pallido più del solito, gli occhi vuoti come vetro. Poi si trasformò. La malattia, fino a quel momento padrona del suo corpo, sembrò abbandonarla. La donna fragile e piegata dal dolore lasciò spazio a una figura violenta, feroce, quasi disumana. Le mani tremanti si fecero artigli. Afferrò la figlia con una forza che Eleonora non avrebbe mai creduto possibile. La trascinò fuori di casa, giù per le scale, in auto. Non disse nulla. Guidò con una determinazione folle fino allo studio privato della sua amica ginecologa, dove Eleonora fu sottoposta a un test di gravidanza senza che nessuno si preoccupasse di chiederle qualcosa.
Negativo.
Il sollievo fu assente. Sua madre non cercava conferme: cercava una punizione. Al ritorno, la casa era fredda, le finestre chiuse, l’aria immobile. Solo allora la madre parlò. Le si mise davanti, la guardò con occhi brucianti, e disse: «Anche se non sei incinta, questa cosa te la porterai dentro per sempre. Come un veleno.»
Eleonora ricordò il suono della sua voce, stridulo e sfinito, e il modo in cui quelle parole sembravano scolpirsi nel legno della porta, nello spazio stesso della stanza. Non le aveva lette: le aveva sentite. Eppure, per anni, il ricordo era rimasto nascosto, protetto da un meccanismo che ora stava crollando.
Ma non era finita. Non era quello, il ricordo che la stava soffocando davvero. Quel momento era solo l’inizio. La furia della madre non si era placata. E ciò che accadde in seguito era ancora sepolto nell’ombra, pronto ad emergere con una tremenda brutalità.
9
L’improvvisa interruzione dell’esperimento arrivò come una frattura, netta e violenta, nella mente di Eleonora. Il sistema che aveva programmato per monitorare l’intensità dei suoi segnali neurali, una precauzione che in origine le era sembrata quasi eccessiva, era intervenuto con tempestività appena le sue onde cerebrali avevano raggiunto livelli di stress e instabilità troppo elevati. Lo schermo lampeggiava frenetico, mostrando allarmi silenziosi, grafici impazziti, dati caotici che testimoniavano l’immensa pressione a cui aveva sottoposto la sua psiche. Si risvegliò tremando, il sudore freddo che le colava lungo la schiena, il respiro affannato come dopo una fuga disperata.
Ci volle del tempo per riuscire a calmarsi, seduta nell’ombra, circondata solo dal ronzio rassicurante delle macchine. Con un gesto automatico e quasi disperato, cominciò ad analizzare i dati appena raccolti. Non poteva fare altro, non poteva semplicemente abbandonarsi a quel terrore appena vissuto. E lentamente si rese conto che l’esperimento, per quanto terrificante, aveva funzionato. Aveva portato alla luce ricordi autentici, profondamente radicati e sigillati nel suo subconscio, frammenti di verità che, fino a quel momento, erano rimasti completamente nascosti alla sua memoria consapevole.
Eppure, non era abbastanza. Non era pronta a scavare più a fondo, non ancora. Quelle immagini, quelle sensazioni così vive e così dolorose non erano più soltanto turbamento: erano terrore puro, angoscia che minacciava di inghiottirla. Non voleva andare oltre, non voleva rischiare di rivivere ciò che era ancora più oscuro, più pericoloso, ciò che sapeva di aver confinato nelle profondità più nascoste della propria mente.
Con un senso di sconfitta amara, Eleonora sospese immediatamente l’esperimento. Cercò persino di creare una procedura rudimentale per sigillare nuovamente quei ricordi, una primitiva applicazione della sua teoria originale: isolare i traumi con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Ma bastò poco per rendersi conto che quella strada era ancora impraticabile. I modelli di AI a sua disposizione non erano ancora sufficientemente addestrati, e rischiava di creare più danni di quanti ne avrebbe potuti sanare.
Per la prima volta, affrontò la possibilità concreta che tutta la sua ricerca fosse irrealizzabile. Lei stessa, con tutta la sua determinazione e conoscenza scientifica, era quasi collassata sotto il peso di ricordi parziali, appena riaffiorati. Come avrebbe potuto imporre ad altri esseri umani un simile viaggio dentro il proprio inferno interiore? Come avrebbe potuto sottoporre qualcuno a quella sofferenza devastante, riportando in superficie traumi che il cervello aveva giustamente deciso di cancellare?
Seduta lì, nel buio della stanza, Eleonora pensò a cosa poteva fare.
10
La telefonata con Andrea arrivò come un’interruzione inaspettata nel lento scorrere dei giorni. La voce del fratello, calma e rassicurante, risuonò dall’altra parte del telefono con un tono che Eleonora trovò sorprendentemente familiare e distante allo stesso tempo.
«Mi dispiace per la casa» disse lei subito, quasi per prevenire ogni possibile rimprovero. «Pensavo fosse più semplice venderla, ma è tutto più complicato del previsto. E poi, sai, sono immersa nelle mie ricerche e non sono riuscita a seguire tutto come avrei dovuto.»
Andrea sospirò leggermente, con un tono di sincera comprensione. «Ele, non devi scusarti. Non abbiamo fretta, prenditi tutto il tempo necessario. Non dobbiamo per forza regalarla a qualcuno pur di togliercela di mezzo.»
Lei si rilassò, grata per la comprensione del fratello, ma non era ancora del tutto tranquilla. C’era una domanda, improvvisa, che si era insinuata nella sua mente, alimentata dai ricordi da poco riaffiorati.
«Andrea, senti…» cominciò, cercando di trattenere la voce che minacciava di tremare. «Ti ricordi di Claudio?»
Un breve silenzio, poi un sospiro quasi disgustato. «Certo che me lo ricordo. Come potrei dimenticare quell’uomo? Un verme. Ha abbandonato mamma nel momento peggiore, sparendo nel nulla senza dire una parola, senza preoccuparsi di quello che avrebbe lasciato dietro di sé. E lei era già stata lasciata da nostro padre, come se non bastasse.»
Un silenzio pesante scese tra loro. Eleonora non disse nulla, trattenendo dentro di sé il groviglio di emozioni che la stava soffocando. Fu Andrea a riprendere per primo il discorso, con una nota improvvisa di curiosità:
«Sai cosa mi è venuto in mente adesso che me ne hai parlato? Il garage che mamma aveva comprato insieme a Claudio ai tempi della prima malattia, quando noi eravamo ancora ragazzini. Te lo ricordi?»
Eleonora si bloccò, sentendo una strana scossa percorrerle la schiena. «No… che garage?»
«Lo avevo completamente dimenticato» proseguì Andrea, come perso in quel ricordo recuperato all’improvviso. «Lei aveva ottenuto la proprietà completa, dopo che Claudio era sparito, ma non so proprio cosa ne abbia fatto. Non aveva più la macchina da anni, probabilmente ci saranno solo cianfrusaglie…
Dovrebbe essere lì vicino, a pochi isolati dalla casa, ricordi il vecchio parco? Quello con l’altalena rotta e il chiosco che vendeva gelati d’estate? Ecco, il garage è proprio nella stradina dietro quel parco, a fianco dell’officina meccanica che c’è sempre stata.»
Eleonora restò in silenzio, il cuore che batteva più veloce, un’improvvisa curiosità che iniziava a bruciarle dentro.
«Faresti bene a passare a controllare in che condizioni è… dovrebbe avere un certo valore oggi» continuò Andrea con una leggera distrazione nella voce, ignaro della tensione che stava provocando nella sorella.
Eleonora sentì la gola asciugarsi improvvisamente. «Sì, hai ragione,» rispose, cercando di mascherare l’agitazione. «Andrò a vedere.» Chiuse la chiamata con il cuore che le martellava nel petto.
11
Eleonora trovo la chiave con scritto “garage” nascosta in un vecchio portagioie della madre, mischiata a bigiotteria ormai annerita dal tempo. Il metallo freddo della chiave sembrava bruciarle la pelle mentre la stringeva nel pugno, evocando sensazioni che aveva tentato a lungo di seppellire. Camminò lentamente, quasi trascinata da una forza che non comprendeva fino in fondo, fino a raggiungere il garage. L’edificio, stranamente, non aveva l’aspetto abbandonato che si sarebbe aspettata dopo tanti anni: la porta era solo leggermente arrugginita, la serratura cedette con una facilità inquietante. Nei dintorni nessuno sembrava badare a lei.
Entrò lentamente, l’aria umida e stagnante le avvolse il viso, riportandola indietro con una precisione spietata. Davanti a lei, sotto la polvere accumulata, c’era l’auto di sua madre, la stessa che guidava quando lei era adolescente. Era priva di targhe, segno evidente che la pratica di rottamazione era stata avviata ma mai conclusa realmente. Eleonora avvertì un brivido lungo la schiena: tutto era ancora lì, cristallizzato nel tempo, in attesa del suo arrivo, quasi fosse una scena predisposta meticolosamente da qualcuno che voleva tormentarla.
Aprì lentamente la portiera, il cigolio metallico le strinse il cuore, riportando alla mente giornate passate in quell’abitacolo, quando ancora non immaginava che la sua vita sarebbe cambiata così radicalmente. Sul sedile trovò dei fogli ingialliti, invasi dalla muffa: riconobbe immediatamente le analisi mediche che sua madre l’aveva costretta a fare tanti anni prima, quando il sospetto di una gravidanza aveva scatenato la sua rabbia incontrollabile. Quelle carte le tremarono tra le mani, amplificando improvvisamente il peso della frase che da anni la perseguitava, quella frase crudele che aveva segnato irrimediabilmente la sua adolescenza.
Le macchine non servivano più. I ricordi stavano emergendo con una violenza autonoma, travolgendola senza pietà. Respirava affannosamente, cercando disperatamente di restare ancorata al presente. Aprì il portabagagli quasi senza pensare, trovandovi una pala arrugginita, coperta di terra secca. A quel punto i flashback divennero insopportabili, come lame che le squarciavano la mente, fendendo ogni residua barriera razionale.
Vedeva sua madre, debole e malata, trasformata da una rabbia che non le era mai appartenuta. Era una donna pacifica, incapace di violenza, eppure ora Eleonora riviveva la scena in cui la madre, come posseduta da una forza innaturale, colpiva brutalmente l’uomo legato a terra, il suo compagno Claudio. La furia della donna si manifestava in gesti terribili, incomprensibili in una figura così fragile e provata dalla malattia. I movimenti erano rabbiosi e determinati, completamente distanti dall’immagine gentile e mite che aveva sempre avuto di lei.
Le immagini si fecero ancora più realistiche, fino a diventare insopportabilmente vivide: ora era lei stessa, non più una semplice spettatrice passiva. Sentiva nelle sue braccia quella stessa rabbia, colpiva quell’uomo con una violenza che non si riconosceva, che non capiva. Era stata sua madre? Era stata lei stessa? O forse entrambe, accomunate da quella furia che aveva spezzato qualcosa di irrimediabile nelle loro anime? Ricordava il viso dell’uomo, deformato dal dolore e dal terrore, i suoi occhi supplicanti che cercavano pietà invano. Quei ricordi la sopraffacevano, la trascinavano in un vortice oscuro che minacciava di inghiottirla completamente.
Con un brivido ancora più intenso, Eleonora si rese conto che il suo esperimento con l’intelligenza artificiale aveva schiuso porte che avrebbero dovuto restare sigillate per sempre. Le macchine avevano lavorato troppo bene, riportando alla luce dettagli e sensazioni con una chiarezza devastante, amplificando ogni emozione fino a renderla quasi fisicamente dolorosa. Sentiva la mente vacillare sotto il peso di ciò che aveva risvegliato, una verità troppo pesante per essere affrontata.
Quella domanda, quel dubbio atroce, penetrò la sua mente come un’ossessione che già sapeva non avrebbe mai potuto superare. Quei ricordi erano troppo intensi, troppo crudeli: Eleonora capì, con una certezza brutale, che non sarebbe riuscita a sopportarli a lungo. Quei ricordi l’avrebbero trascinata inevitabilmente verso la follia, verso un punto di non ritorno.
Epilogo
Un mese dopo.
La stanza era pervasa da una luce blu soffusa, dal bagliore innaturale. Il fratello di Eleonora fissava il corpo immobile della sorella, disteso su un lettino sterile, circondato da cavi e macchinari silenziosi che emettevano un lieve e costante ronzio. Sembrava dormire, con un’espressione pacifica che appariva del tutto fuori luogo rispetto alla gravità della situazione; lui, però, era consapevole che dietro quella calma apparente si celava qualcosa di ben più complicato. Il tempo, per lei, non scorreva: era sospeso tra speranza e disperazione.
«Che è accaduto esattamente?» chiese, senza distogliere lo sguardo dal volto di lei.
La collega di Eleonora, una donna minuta dal volto severo e stanco, i capelli raccolti con cura dietro la nuca, inspirò lentamente prima di rispondere. Le sue mani sottili si mossero con nervosismo sulle pagine di una cartella clinica che teneva stretta.
«Abbiamo analizzato con estrema attenzione tutti i dati e i log del computer di Eleonora. Sappiamo con certezza che ha usato sé stessa come soggetto sperimentale. Era determinata a recuperare ricordi che il cervello aveva sepolto nell’inconscio per proteggerla da qualcosa vissuto nel passato, probabilmente durante l’adolescenza. Ricordi che evidentemente erano troppo dolorosi e traumatici per essere affrontati. Aveva sviluppato un metodo innovativo per accedere a queste memorie: una sorta di auto-terapia neurale, in cui sperava di rivivere tutto per poi riuscire a isolare quei ricordi in modo permanente, rendendoli innocui.»
«E invece?» Il tono dell’uomo era carico di amarezza, la voce spezzata dal peso delle sue paure più profonde.
«Qualcosa è andato storto,» continuò la ricercatrice, con voce piatta, cercando di mantenere la freddezza professionale. «La procedura era incompleta, troppo instabile. Deve aver percepito che stava perdendo il controllo. A quel punto ha preferito lasciarsi intrappolare volontariamente in questo stato REM prolungato, piuttosto che affrontare fino in fondo ciò che aveva risvegliato.»
Il fratello chiuse gli occhi per un istante, cercando di ricacciare indietro un’ondata di nausea e disperazione. Aveva la sensazione che il pavimento stesse vacillando sotto i suoi piedi.
«Che cos’era di così terribile? Io la ricordo come un’adolescente normale» chiese infine, temendo la risposta più della domanda stessa.
La donna gli rivolse uno sguardo fermo, deciso, quasi protettivo: «Non lo sappiamo. Nessuno lo sa, a parte lei. È sepolto profondamente nella memoria di Eleonora, e probabilmente lo era anche in quella di vostra madre. Non può essere un caso che tutto si sia scatenato poche settimane dopo il ritorno nella casa d’infanzia. Qualunque cosa sia, deve restare sepolta.»
«Quindi mia sorella resterà così per sempre?» domandò lui, con voce incrinata dalla paura e dall’impotenza.
«No, non necessariamente,» rispose la collega con prudenza. «Abbiamo tutti i dati sperimentali, conosciamo esattamente ogni passaggio di ciò che ha fatto. È possibile invertire il processo e svegliarla. I nostri modelli di intelligenza artificiale stanno stimolando il suo cervello in modo mirato e attento. Siamo molto fiduciosi. Ma questa storia, qualunque essa sia, dovrà rimanere sepolta. Definitivamente. Non possiamo permettere che Eleonora ripercorra di nuovo quell’incubo.»
Il silenzio calò pesante tra loro, interrotto soltanto dal debole e monotono suono delle macchine.
«Non indaghi, non cerchi risposte» aggiunse la collega, con voce ferma ma gentile. «La scelta migliore è rispettare il desiderio di Eleonora. Qualunque cosa abbia visto, appartiene al passato. È là che deve restare.» Lui annuì lentamente, consapevole della gravità delle parole che aveva appena ascoltato. Posò delicatamente una mano sulla spalla immobile della sorella, incapace di dire addio o di promettere qualcosa che non poteva garantire. Si allontanò lentamente, quasi a fatica, dalla stanza, lasciando Eleonora avvolta in quel sonno profondo, sospesa in un limbo che forse, dopotutto, era diventato la sua unica salvezza, l’unico rifugio da un passato che non poteva essere cambiato, ma solo dimenticato.



