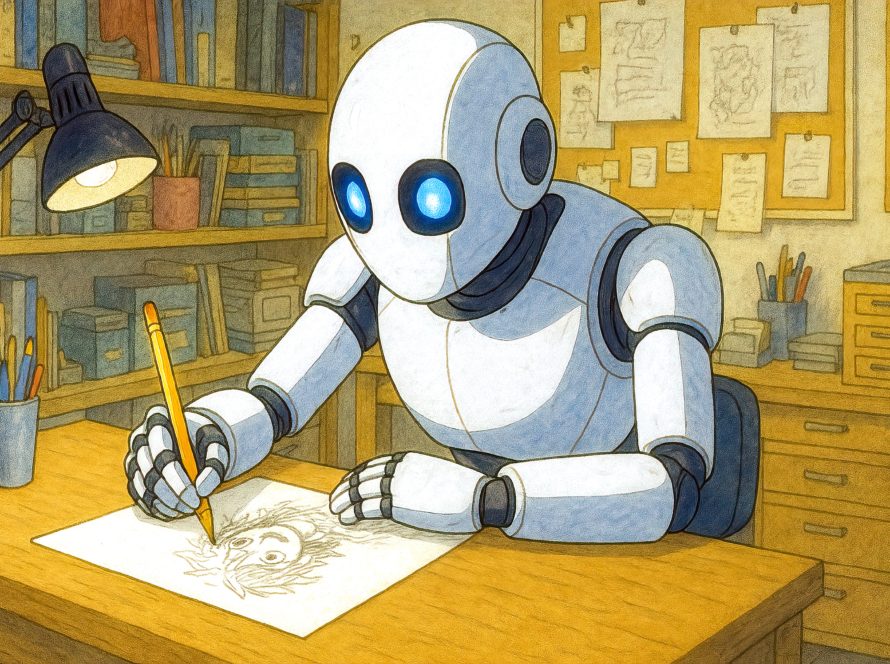Nel suo primo discorso al Collegio cardinalizio, Papa Leone XIV ha collocato l’intelligenza artificiale tra le priorità del suo pontificato. «La Chiesa deve rispondere a un’altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell’intelligenza artificiale», ha dichiarato, sottolineando come queste trasformazioni pongano nuove sfide per la giustizia sociale, il lavoro e la dignità umana. La scelta del nome Leone, in continuità con Leone XIII e la sua Rerum Novarum, segnala la volontà di affrontare i mutamenti in atto con uno sguardo ampio, simile a quello riservato ai conflitti sociali generati dalla rivoluzione industriale. L’AI, per il nuovo Pontefice, è già oggi una “questione sociale” che merita attenzione e discernimento.
La posizione della Chiesa cattolica rispetto all’intelligenza artificiale si distingue per un equilibrio tra apertura e cautela. Da un lato, viene riconosciuto il potenziale positivo di queste tecnologie, soprattutto se utilizzate per il bene comune. Dall’altro, emerge la necessità di interrogarsi su aspetti più profondi: cosa accade se l’AI non è più solo uno strumento, ma diventa un sistema in grado di prendere iniziative proprie?
Nei documenti ufficiali recenti, la questione non viene mai affrontata nei termini specifici dell’AGI o della superintelligenza, ma si coglie una preoccupazione crescente. In particolare, si osserva con attenzione il superamento di alcune soglie: l’AI che apprende, si adatta, elabora soluzioni in autonomia, inizia a operare in ambiti decisionali un tempo riservati all’essere umano.
Durante un intervento al G7 del 2024, papa Francesco ha affermato che «all’essere umano deve sempre rimanere la decisione». Il contesto era quello delle applicazioni militari dell’AI, ma il principio è più ampio: nessuna macchina dovrebbe avere il potere di decidere su vita, morte o libertà. La frase «mai succeda che siano le macchine ad uccidere l’uomo che le ha create», evocava scenari limite, ma non più lontani dalla realtà, considerando l’autonomia crescente di alcuni sistemi.
La preoccupazione non riguarda solo gli impieghi rischiosi dell’AI. Esiste anche un piano più sottile, che tocca la definizione stessa di umanità. Se una tecnologia riesce a generare linguaggio, a interagire, a prendere decisioni complesse, quanto rimane distintiva la coscienza umana? Questo tipo di interrogativi non appartiene solo al dominio teologico, ma coinvolge l’etica, l’antropologia, la filosofia della mente. La riflessione su ciò che distingue l’essere umano da una macchina intelligente è destinata a diventare centrale nei prossimi anni.
Nel frattempo, la Chiesa partecipa attivamente a tavoli di confronto e promuove iniziative per guidare lo sviluppo dell’AI con criteri condivisi. La Rome Call for AI Ethics, firmata da istituzioni religiose, aziende tecnologiche e organismi internazionali, punta a garantire che l’AI resti sotto controllo umano, sia trasparente, non discriminatoria, orientata al bene comune. È un invito a non lasciare il futuro nelle mani del mercato o di pochi attori dominanti.
Sul piano più speculativo, si apre una riflessione ancora poco esplorata: e se un giorno emergessero segnali di coscienza o intenzionalità nelle macchine? Alcuni osservatori iniziano a interrogarsi anche su un altro aspetto, finora marginale: la possibilità che i modelli AI più avanzati acquisiscano capacità cognitive, percettive e decisionali che superano quelle umane in settori specifici o in combinazione, fino a invadere metaforicamente – o concettualmente – il campo del divino. Non perché simulino una fede, ma perché potrebbero proporre risposte, visioni del mondo o forme di autorità che competono con l’idea stessa di trascendenza o di senso ultimo. e se un giorno emergessero segnali di coscienza o intenzionalità nelle macchine? La domanda resta sullo sfondo, ma l’interesse della Chiesa per questi temi suggerisce che non si tratti solo di una questione tecnica. In gioco non c’è soltanto la sicurezza dei sistemi, ma la tenuta dei riferimenti culturali, sociali e morali che finora hanno definito l’identità umana.
L’attenzione verso l’intelligenza artificiale, dunque, non nasce da un timore ideologico, ma da una consapevolezza crescente: stiamo vivendo l’inizio di una trasformazione che può ampliare le possibilità umane ben oltre i limiti tradizionali. L’AI non è soltanto uno strumento, ma una leva capace di accelerare il progresso in ambiti cruciali come la medicina, l’istruzione, l’ambiente, la comunicazione e la ricerca. La prudenza, in questo caso, è parte di una responsabilità condivisa, ma non deve oscurare il potenziale straordinario di queste tecnologie. Che la risposta provenga dalla teologia, dalla scienza o dalla società civile, è sempre più necessario un confronto aperto e fiducioso su quale visione dell’essere umano vogliamo promuovere in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale può rendere il sapere più accessibile, il lavoro più creativo, le società più eque e interconnesse.